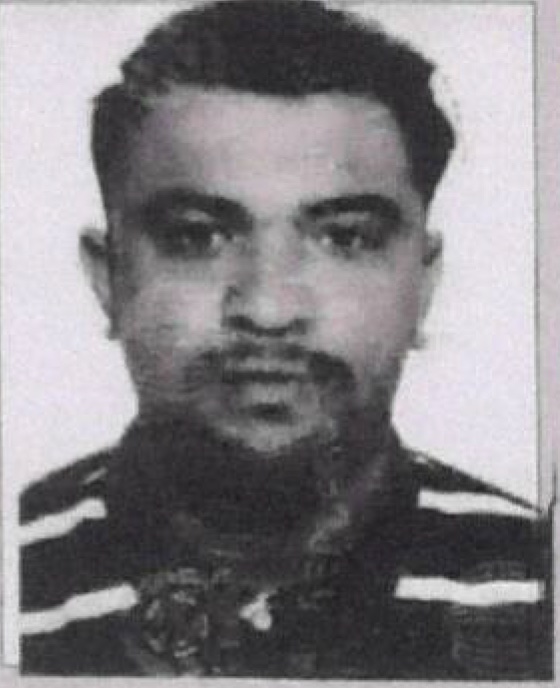L’uccisione di una persona fa presumere, da sola, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli ed ai fratelli della vittima: tale circostanza non abbisogna di prove e a nulla rileva che che le parti non convivessero né che fossero distanti. Con una cristallina ordinanza, la n. 3767/18, depositata il 15 febbraio, la Corte di Cassazione ha fornito importanti elementi circa l’applicazione del riparto dell’onere della prova in caso di decesso causato da un incidente stradale, “bacchettando” la Corte di merito.
Nel 2009 i familiari di un giovane di origine rumena, investito mortalmente da un autocarro nel 2008, citarono in causa il conducente del mezzo, il proprietario e la compagnia di assicurazione, UnipolSai, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Nel 2014 il Tribunale rigettò la domanda, mentre nel 2015 la Corte d’Appello di Milano (in foto), in accoglimento parziale del gravame proposto dai soccombenti, accolse la domanda di risarcimento proposta dalla moglie e dai figli della vittima, addossando tuttavia a quest’ultima un concorso di colpa del 50%, ma rigettò la domanda della madre e dai fratelli della vittima, ritenendo non provata una “effettiva compromissione di un rapporto affettivo in essere al momento del fatto”. E inoltre, ritenuto che il danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai figli della vittima dovesse essere “ragguagliato alla realtà socioeconomica in cui vivono i soggetti danneggiati”, accertato che essi risiedevano tutti in Romania, ridusse del 30% il risarcimento che avrebbe altresì liquidato a persone residenti in Italia.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da tutti i congiunti della vittima, con ricorso fondato su tre motivi. La Suprema Corte ha accolto innanzitutto il primo: secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 2043 e 1223 c.c., per avere ridotto il risarcimento in considerazione del loro luogo di residenza, ovvero la Romania. “Questa Corte, infatti – recita l’ordinanza – ha già ripetutamente affermato che “la realtà socioeconomica nella quale vive la vittima d’un fatto illecito è del tutto irrilevante ai finì della liquidazione del danno aquiliano” (così Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 12221 del 12/6/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 13/11/2014)”.
Ma qui a interessare è soprattutto la posizione della Cassazione sul terzo motivo, parimenti accolto, del ricorso, nel quale i familiari della vittima lamentavano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che la Corte d’appello avesse violato gli artt. 2043, 2059, 2727 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c., nel rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla madre e dai fratelli della vittima, sulla base del presupposto che non fosse provata l’esistenza d’un vincolo affettivo tra la vittima da un lato, la madre e i fratelli dell’altro. I ricorrenti sostenevano, al contrario, che l’esistenza di tale vincolo affettivo non era stata contestata dalla compagnia di assicurazioni, che anzi l’aveva ammessa, e che, in ogni caso, la semplice esistenza del rapporto di filiazione o di fratellanza era di per sé idonea a far presumere, ex art. 2727 c.c., l’esistenza d’un vincolo affettivo tra la vittima, la madre ed i fratelli.
“La Corte d’appello – sentenziano gli Ermellini – ha rigettato la domanda proposta dalla madre e dai fratelli della vittima affermando che quest’ultima si era trasferita dalla Romania in Italia sin dal 1992, e che “non vi è prova alcuna del permanere di rapporti con la famiglia di origine”. Così giudicando, però, la Corte d’appello ha addossato a una madre l’onere di provare di avere sofferto per la morte d’un figlio, ed altrettanto ha fatto per i fratelli. Questa statuizione non è conforme al diritto. In linea generale, non v’è dubbio che spetti alla vittima d’un fatto illecito dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e di conseguenza l’esistenza del danno. Tale prova tuttavia può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l’id quod plerumque accidit. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all’essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre d’una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite. Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava alla madre ed ai fratelli della vittima provare di avere sofferto per la morte del rispettivo figlio e fratello, ma sarebbe stato onere dei convenuti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte della vittima lasciò indifferente la madre ed i fratelli”.
Inoltre, sottolinea la Cassazione, “la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’indifferenza d’una madre alla morte del figlio. Lo insegna la psicologia (dalla quale apprendiamo che la lontananza, in determinati casi, rafforza i vincoli affettivi, a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla); lo testimonia la storia (qui gli esempi sono sterminati: dal carteggio di Abelardo ed Eloisa alle lettere dei condannati a morte della Resistenza), e lo attesta sinanche il mito (…). La Corte d’appello ha dunque effettivamente violato sia l’art. 2727 c.c., perché ha negato rilievo a un fatto di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza del danno (il rapporto di filiazione e di fratellanza), sia le regole sul riparto dell’onere della prova, addossando agli attori l’onere di provare l’assenza di fatti impeditivi della propria pretesa”.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata anche su questo punto, “in virtù del seguente principio di diritto cui si atterrà il giudice di rinvio (la Corte d’Appello di Milano, ndr)– conclude e statuisce la Suprema Corte – “L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostante, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati